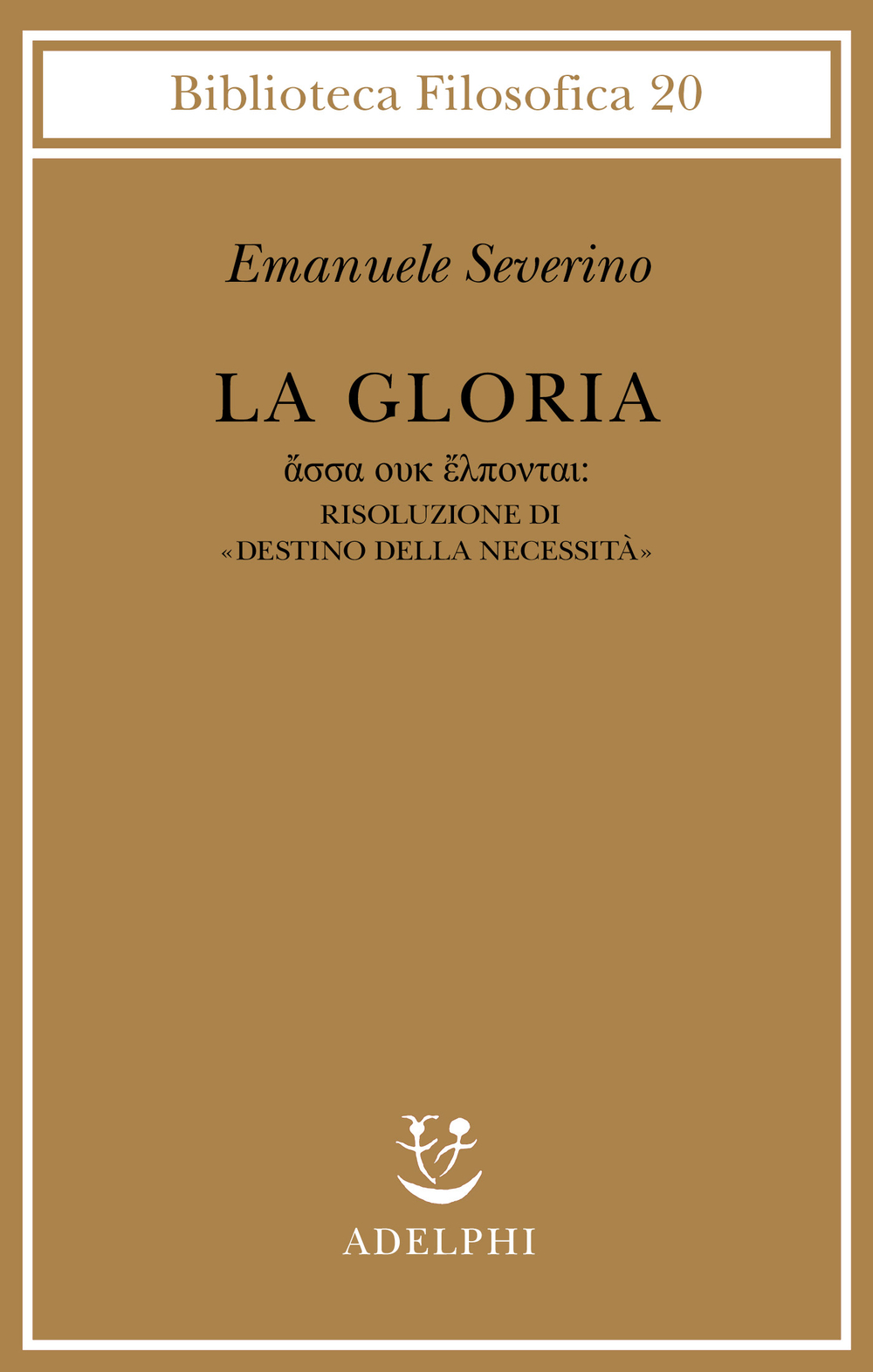
2020 / pp. 135 / € 11,00 € 8,80
2020 / pp. 135 / € 11,00 € 8,80
-
Piccola Biblioteca Adelphi
1979 / pp. 147 / € 12,00 € 9,60 -
Adelphi eBook
2020 / pp. 135 / € 5,99
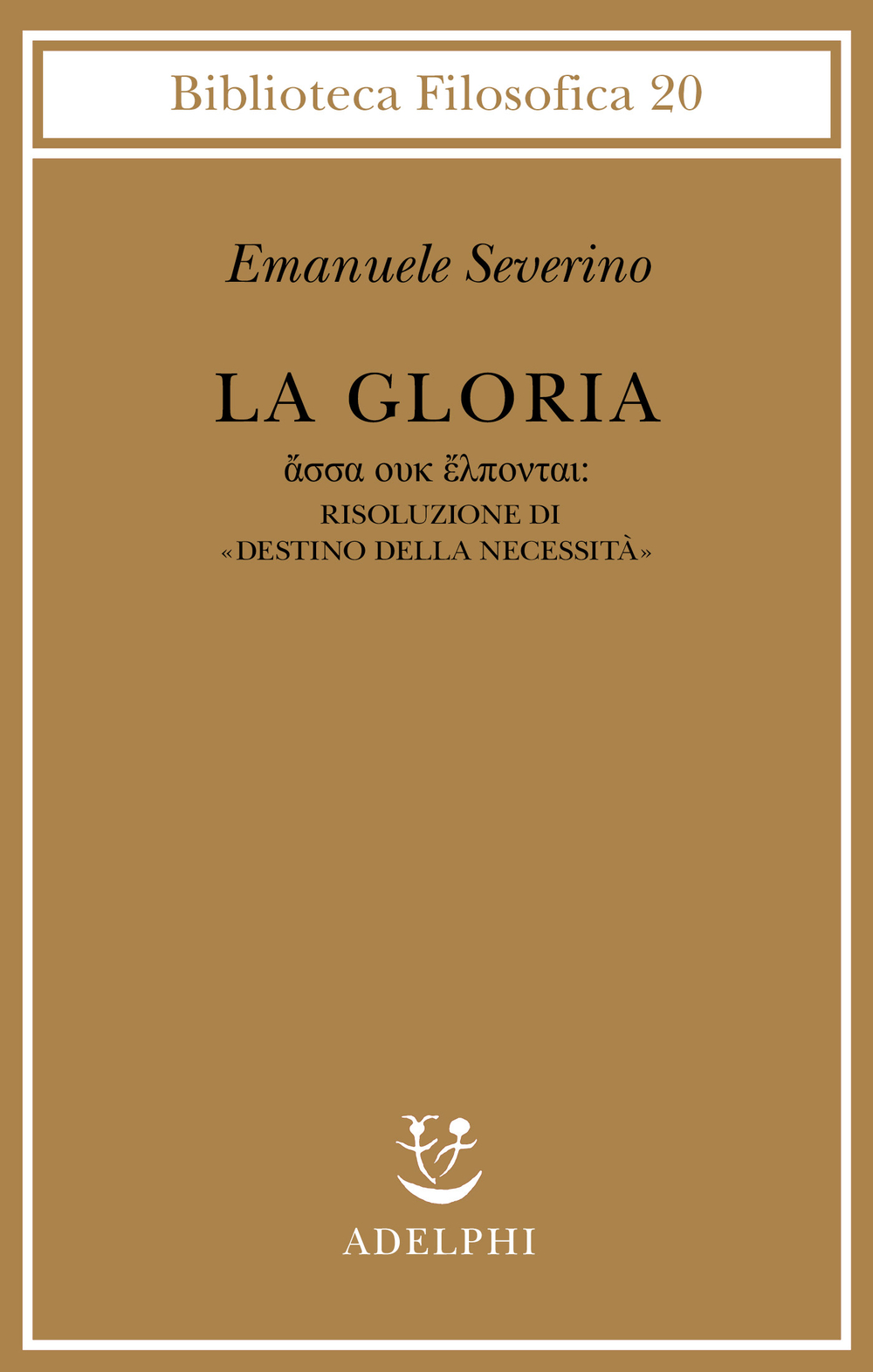
Destino della necessità, l’opera di Severino su cui tutte le altre paiono convergere, si chiudeva con la promessa di una seconda parte che avrebbe fornito la «risoluzione», cioè la risposta alle domande più gravi e più sorprendenti lì evocate. Ora, a distanza di ventun anni, quella promessa viene mantenuta – e l’esito è non meno audace che folgorante. Nei libri di Severino la pars destruens sulle tesi fondamentali del pensiero occidentale è sempre basata sulla pars construens, che mostra come si configura e che cosa implica un pensiero non fondato sul presupposto che gli essenti sorgano dal nulla e al nulla ritornino. Ma nella Gloria la dimensione costruttiva si spinge sino ai più lontani confini: alla Gioia, termine già presente in Destino della necessità e inusuale nel discorso filosofico, si appaia la Gloria, termine che ha un lungo passato, ma teologico più che filosofico. E di conseguenza l’uomo stesso – ovvero il soggetto che legge – scoprirà di essere, da sempre, qualcosa di radicalmente diverso da ciò che suppone di essere. Che è appunto la più alta ambizione del pensiero in genere.