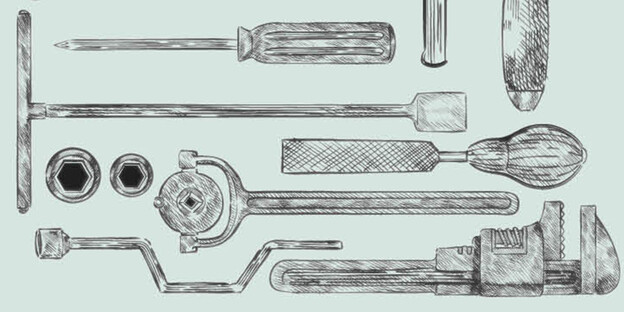«Il romanzo più importante di quest’uomo resta sempre Riso nero, della, diciamo, seconda maniera: che riassume entro di sé tutti i motivi sparsi negli altri racconti dal ’16 in qua – qualche volta anche più chiari, più riusciti, ma non mai tanto definitivi.
È la storia di un giornalista di Chicago che si secca e sente inutile nella vita che conduce a contar fandonie alla nazione e a gironzare per i salotti colla moglie intellettuale e romanziera. Qualche volta va a ubriacarsi col collega, ma finiscono soltanto per parlare d’impotenza e di degenerazione. Finché un giorno pianta tutto, muta nome e se ne scende ozioso in treno e in barca per il Mississippi, fino a Nuova Orleans. Qui s’impregna di molle far niente e di risa, di canto, di spirito negro. Poi risale e si ferma ad Old Harbor, Indiana, dov’è vissuto in fanciullezza e s’impiega – operaio – a dipingere ruote d’auto in una fabbrica fattiva, “americana”, che lo lascia indifferente.
Il racconto comincia solo ora, ma la materia è quella che ho detto. Poiché Bruce Dudley – il nuovo nome – è un Sherwood Anderson completo, e fantastica, pensa, rivive, “racconta a se stesso”, indolente, a riprese, a legami leggeri coi fatti di Old Harbor, la vita passata.
Gli si accende nel ricordo – ad un ritmo pensoso e indolentemente solenne, di periodi – il gran tempo del Fiume, quando la vita americana “vera”, di gente che rideva e cantava, si muoveva sul Mississippi ed i negri eran negri e Mark Twain, non ancora ingabbiato dalle idee puritane – la Nuova Inghilterra, la negazione dell’America – ne creava la favola eroica coi libri di Tom Sawyer e di Huckle Finn. Poiché Bruce Dudley (Sherwood Anderson) è, come ho detto, un narratore e non vede nella vita che lo sforzo di un racconto ed ha quel modo di parlare così lento e pensieroso perché tutto quel che dice gli si travaglia in mente trasformandosi in racconti. Questa che potrebbe essere la rovina dello scrittore, gli si fa invece la sua poesia, poiché nessuno è più lontano dalla letteratura e più “vivente” di lui, nessuno più innamorato delle cose e del mondo, in un modo ch’è quasi sensuale Lo stile di Anderson! Non il dialetto crudo ancora troppo locale ma una nuova intramatura dell’inglese, tutta fatta d’idiotismi americani, di uno stile che non è più “dialetto”, ma “linguaggio”, ripensato, ricreato, “poesia”» (Cesare Pavese, da La letteratura americana e altri saggi).